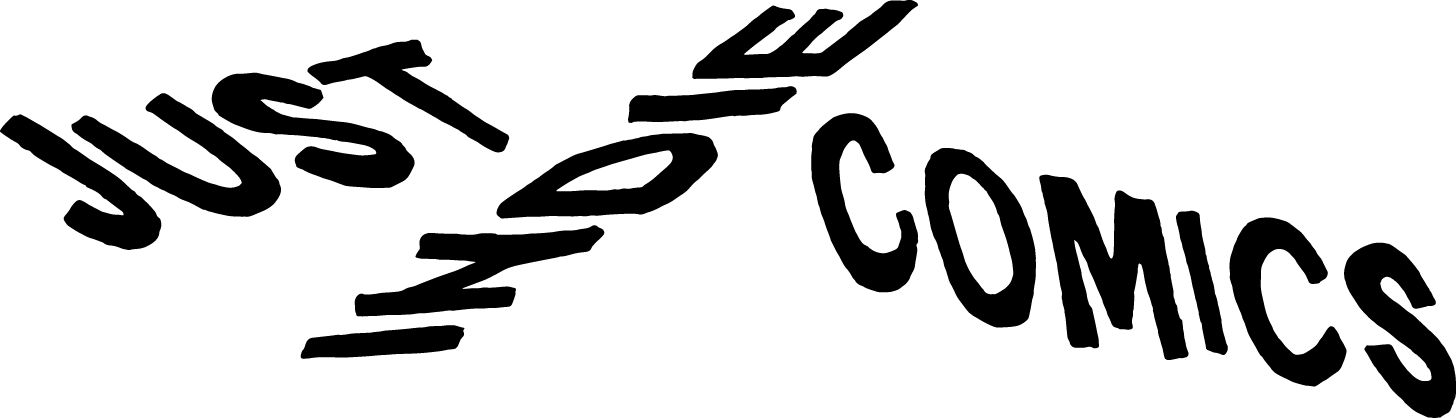di Emil Ferris, Bao Publishing, aprile 2018, brossurato, 416 pagine a colori, 20.5 x 25.7 cm, euro 29
Karen Reyes è una bambina di 10 anni che vive con la madre e il fratello più grande nella Chicago dei tardi anni ’60. Appassionata di film fantasy e horror, è affascinata dall’immaginario dei b-movie e delle riviste a tal punto da rappresentarsi nel suo diario illustrato come un lupo mannaro. Un giorno la bella vicina di casa Anka Silverberg viene trovata morta nell’appartamento al piano di sopra. La polizia parla di suicidio ma Karen non è per niente convinta. Inizia così un’indagine che la porterà ad esplorare il passato della donna, fino a scoprirne le sofferenze patite nella Germania pre-nazista, tra povertà, prostituzione minorile e deportazione in un campo di concentramento. Nel frattempo la mamma di Karen si ammala, il fratello va dietro a ogni donna che incontra, la stessa ragazzina comincia a comprendere la propria sessualità. E, nel finale di questo primo volume, viene ucciso Martin Luther King.
E’ questa a sommi capi la trama di La mia cosa preferita sono i mostri, il finto diario di Karen Reyes raccontato da Emil Ferris, autrice classe 1962 che ha debuttato con la prima opera lunga proprio con questo fumetto. Pubblicato dalla Fantagraphics Books di Seattle alla fine del 2016, il libro è rimasto bloccato per diverse settimane a causa di problemi legati alla spedizione delle copie dalla Corea, dove si trovava la tipografia. Uscito di fatto nel 2017, è stato il fumetto più citato nelle classifiche di fine anno scorso negli USA, oltreché un caso editoriale che ha portato Fantagraphics a ristampare più volte la prima tiratura. Ma di My Favorite Thing Is Monsters si è parlato anche per la tormentata storia della sua autrice, capace di realizzare una titanica opera di 400 pagine (in attesa del seguito, per giunta) dopo essere rimasta paralizzata a 40 anni in seguito a un pizzico di zanzara con cui ha contratto il virus del West Nile. Ma non vi tedierò ulteriormente con questa storia, che alcuni di voi già conosceranno (gli altri la possono leggere in questo fumetto realizzato dalla stessa Ferris).
Ho pensato più e più volte a come considerare La mia cosa preferita sono i mostri, sin dalla sua uscita negli USA. Ci ho pensato anche quando ho stilato il mio Best Of del 2017, in cui alla fine non ho inserito il libro di Emil Ferris perché la prima lettura mi aveva lasciato interdetto. Così quando, all’inizio di aprile, Bao Publishing lo ha pubblicato in Italia in un’edizione identica all’originale, mi è sembrata l’occasione giusta per rileggerlo e rivedere eventualmente il mio giudizio. E invece sono rimasto nuovamente interdetto, perché ai suoi innegabili pregi l’opera unisce più di qualche difetto.
In parte forse è un mio problema. Problema con quei fumetti che pur servendosi delle soluzione tipiche del medium – come le nuvolette, i dialoghi, le vignette – tendono a utilizzare le immagini più per accompagnare il testo che per raccontare. Da anni imperversa ormai il termine graphic novel, che i più utilizzano per dare maggiore dignità al fumetto, spesso per prodotti che di “novel” hanno ben poco. Qui per una volta si potrebbe utilizzare il termine a proposito perché siamo di fronte a un vero romanzo grafico, un’opera al cui centro c’è un fiume di parole e in cui le immagini sono al servizio di queste. Un romanzo di formazione che sembra rimandare più alla narrativa americana contemporanea che ad altri fumetti, anche se un riferimento diretto potrebbe essere Fun Home di Alison Bechdel, non a caso chiamata a dire la sua in quarta di copertina.
Ma anche provando a mettere da parte questa mia idiosincrasia per la narrativa a fumetti nel senso più stretto del termine – ed è una cosa del tutto personale, perché il fumetto può ovviamente essere anche questo – La mia cosa preferita sono i mostri non funziona sotto diversi punti di vista. E’ soprattutto il lungo flashback nella Germania pre e poi nazista a lasciare perplessi, tanto è pieno di luoghi comuni e di personaggi artificiosi. Il parallelismo tra la protagonista e la giovane Anka, suggerito dall’autrice, non regge. Tanto è ben delineata e interessante la prima, tanto risulta macchiettistica la seconda. E, pur volendo sospendere l’incredulità sull’io narrante nelle diverse fasi della storia, sembra difficile accettare che il punto di vista di Karen risulti in molte parti più maturo di quello di Anka, che racconta su nastro le traumatiche esperienze d’infanzia con il punto di vista di un’adulta, poco prima della sua morte. E’ forse lì che il racconto cede il passo, si appesantisce, smette di appassionare, come se l’autrice si trovasse a suo agio con il suo mondo – la Chicago dei tardi anni ’60 in cui è cresciuta – ma non con qualcosa a lei estraneo come la storyline sul passato di Anka, intrisa di atmosfere alla Dickens ma al tempo stesso di manierismo. Anche il disegno, che nella parte moderna unisce immaginario da b-movie, richiami a maestri dell’illustrazione come Sendak e splendido realismo nella rappresentazione dei volti umani, si concede momenti sin troppo ordinari nelle pagine ambientate in Germania, a volte naif nel senso peggiore del termine. E in realtà è tutto il libro che alterna a livello grafico momenti alti e bassi, tra tavole stupefacenti ed altre funzionali al racconto ma sin troppo abbozzate per risultare finite. Tra l’altro le più riuscite si trovano per lo più nella prima parte, come se a un certo punto per portare a termine la titanica impresa la Ferris sia stata costretta ad accelerare il passo e semplificare il disegno.
Detta così, La mia cosa preferita sono i mostri sembrerebbe uno di quei libri belli soltanto da sfogliare. Di sicuro la mole, l’iconografia e l’indiscutibile fascino di alcune tavole hanno influenzato la maggior parte di critici e lettori, che hanno gridato al capolavoro ancor prima di leggerlo. Eppure non è tutto qua, perché di cose positive il libro ne ha eccome. C’è innanzitutto il mondo visto dagli occhi di una bambina che in alcuni passaggi restituisce atmosfere di romanzi come Il Giovane Holden o Molto forte, incredibilmente vicino, con la riflessione finale su chi sono i veri mostri che solo una bambina può fare con tanta lucidità. C’è la riuscitissima sequenza onirica iniziale, con la protagonista che sogna di essere un lupo mannaro e una folla inferocita che la bracca per ucciderla. Ci sono i turbamenti sessuali di Karen, il suo difficile rapporto con il proprio corpo e le difficoltà relazionali che ogni ragazzo ha avuto in un momento o nell’altro della crescita. C’è l’atmosfera della Chicago anni ’60, le sue strade, i quartieri e la metropolitana, così vividamente realistici. C’è la riproduzione delle copertine di fumetti e riviste di genere, materiale con cui la Ferris è tremendamente a suo agio. Com’è a suo agio quando fa percorrere a Karen i corridoi dell’Art Institute, non limitandosi a ricreare brillantemente con penne e matite colorate alcuni classici della pittura, da Seurat a Delacroix, ma entrandoci dentro in modo da restituirne la magia al lettore. Tutte cose che valgono senz’altro il prezzo del biglietto ma che al tempo stesso lasciano anche un po’ di amaro in bocca. Come il sapore di un’occasione sprecata.