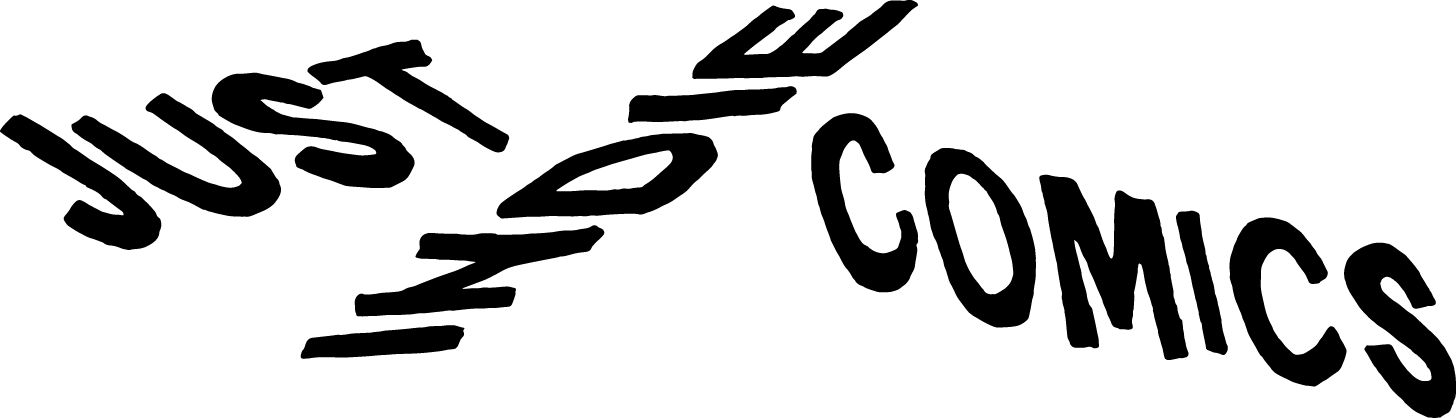Si conclude il saggio di Alessio Trabacchini tratto da Prendere posizione. Il corpo sulla pagina, catalogo del festival BilBOlbul 2020 che è possibile acquistare a questo link. Qui trovate invece la prima parte dell’articolo. Buona lettura.
Costruire, distruggere, sognare
La centralità della presenza corporea, l’utilizzo autoterapeutico della narrazione disegnata e un esempio particolarmente consapevole ed efficace dell’uso della self-deprecation come strumento di affermazione di sé. Queste caratteristiche distinguono l’opera di Kominsky-Crumb da quella di molte tra le iniziali compagne di strada, dove la questione del corpo viene nondimeno consapevolmente affrontata, ma con diversi esiti. Le eroine disegnate da Trina Robbins (analogamente a quelle reali da lei studiate) hanno l’obiettivo di riposizionare le donne sul piano del fumetto. Si tratta per lei di lavorare su figure tipiche, rinnovare i miti. Più che distruggere gli stereotipi, l’intenzione sembra quella di farli slittare verso archetipi utili a un percorso di emancipazione.
Melinda Gebbie (1937-), per fare un altro esempio, condivide alla base il programma di Robbins per un rinnovamento della figura femminile in chiave mitica, ma ne sposta il campo dalla luce piena della collega a un territorio di lampi e tenebre, il campo di un desiderio incontrollato e di un disordine famelico. Il corpo ritorna con prepotenza, mentre in Robbins appare come depurato, ma l’intento dell’apollinea Robbins e della dionisiaca Gebbie rimane la creazione di modelli femminili forti, che attacchino frontalmente la tradizione patriarcale del fumetto. La via di Kominsky-Crumb è inizialmente marginale e marginalizzata – a chi può interessare la vita privata di una ragazza qualsiasi, per di più mostrata in quel modo? – , ma diventerà la strada maestra del graphic novel e, in generale, del fumetto non seriale.
Già nella generazione immediatamente successiva, diverse autrici seguono la direzione tracciata da AKC, come Dori Seda (1951-1988), giunta al fumetto dalla pittura e dalla scultura. Nel suo caso, è il gesticolare ampio e disarmonico della protagonista che scuote uno stile grafico piuttosto tradizionale, con i contorni definiti, le ombre portate e un realismo mimetico solidale con la sintesi del cartoon. Il gesto caricato dona qui la misura emotiva del fumetto, ma diventa anche spesso il principio ordinatore della tavola, che sembra assemblarsi attorno ai movimenti della protagonista, sempre in scena. In altre parole, è il corpo che regola (non subisce) caoticamente lo spazio. Sincera provocazione e divertimento esibizionistico che nelle ultime storie assumeranno una direzione chiaramente politica, dove la sincerità risiede in una disponibilità dialogica verso il lettore, disponibilità che si manifesta nelle parole, ma che comincia proprio nel disegno. Qui, il mimetismo dettagliato di Seda si allontana dalla brutalità grafica di Kominsky-Crumb come dal grottesco armonico e rifinito di Crumb per affidarsi a un gesticolare inquieto, sempre in sovraccarico di energia vitale e autodistruttiva: la conquista dello spazio come guerra e come gioco.
Phoebe Gloeckner (1960-) arriva al fumetto molto presto, negli anni della sua traumatica adolescenza. Contemporaneamente, si dedica all’illustrazione medica, che diventa nelle sue mani un esercizio di crudeltà grafica praticato sulla forma e le funzioni del corpo, specificatamente femminile. Nelle illustrazioni per La mostra delle atrocità di James Ballard (RE/Search, 1990), la presunta asetticità dei corpi in sezione accoglie azioni di natura sessuale: erotismo disturbante e ironia freddissima che si accompagnano bene alle suggestioni ballardiane, ma spingono oltre. L’Autoritratto con pemphigus vulgaris (1987) che apre Vita da bambina, esposizione dei traumi vissuti durante l’infanzia e l’adolescenza, vale come prefazione. Porta in collisione i due sguardi oggettificanti sul corpo femminile – dell’arte e della scienza – dirigendo l’attenzione, con un close-up della pustola, sul disgusto. E, mentre mima gli occhi chiusi, se ne prende gioco con un ambiguo sorriso che confonde il dolore con l’ironia.
La malattia è il mezzo della rivolta, e Phoebe Gloeckner ha definito la pratica autobiografica da lei utilizzata come un processo di autodistruzione, contestando l’identificazione con il suo alter-ego Minnie e descrivendolo piuttosto come un processo di sostituzione: “The process is destructive – I must die so that Minnie can live”. La cura (attraverso l’arte) e il sacrificio (per l’arte?) si trovano così in sovrapposizione, mettendo in dubbio la funzione salvifica del racconto sul piano narrativo, ma soprattutto su quello visuale, dove la deformazione cartoonesca innestata su un illusionismo quasi fotografico, la focalizzazione oscillante e l’alterazione delle proporzioni rendono incerta la mappatura del corpo e disorientano lo sguardo e la lettura. L’autobiografia disegnata prenderà, in generale, altre e più comode direzioni.
Nell’opera della canadese Julie Doucet (1965-), una delle fondamentali figure-ponte tra l’eredità dell’underground e l’attuale dominio dell’autofiction, si fondono suggestioni americane e francofone. Nella serie di albi Dirty Plotte, che raccoglie le sue storie dal 1988 al 1998, Doucet mescola comicità e angoscia, volgarità ostentata e una malinconia sottile che avvolge le cose. Anche in questo caso un’influenza crumbiana può sembrare evidente, tanto da portare la storiografia (che spesso nasconde una sorta di criptomaschilismo dietro il nazionalismo palese) a oscurarne altre non meno limpide e chiarificatrici, come, per citarne una, le visioni della francese Nicole Claveloux. In ogni caso, al di là delle fonti d’ispirazione, il percorso di Doucet dalle prime autoproduzioni fino al proclamato abbandono del fumetto – dunque tra la fine degli anni Ottanta e i primi Duemila – ha portato il linguaggio in territori inesplorati. Il suo approccio al racconto di sé – mosaico di intimismo, provocazione, onirismo e fantasticheria – offre una mappatura del corpo e delle sue opzioni profonda e articolata (per approfondire: Anne Elizabeth Moore, Sweet Little Cunt, Uncivilized Books, 2018).
Generalizzando un po’ brutalmente, l’autobiografia confessionale può essere orientata dalla ricerca dell’identità o dall’affermazione del desiderio: l’una definisce l’altro o viceversa. Doucet sembra scegliere la seconda opzione: Julie attraversa il quotidiano, l’onirico e il simbolico venendo volta per volta ridefinita dal contesto e dalle sue azioni, il genere e il sesso vengono continuamente messi in questione, con l’alter ego disegnato dell’autrice che sperimenta a più riprese l’opportunità di avere un pene, oppure si diverte a scompigliare gli stereotipi della mascolinità. Ma è anche il piano della realtà a essere instabile: uno spazio sporco e rigoglioso, ora confortevole ora carico di minacce inquietanti, brulicante di oggetti pronti a prendere vita.
L’intimità che nasce dal contatto con la mente della protagonista, illuminata anche negli angoli che di solito si preferisce lasciare in ombra, convive con la cruda rappresentazione di una violenza che aleggia tra le cose e incombe sui corpi, sul suo. Un corpo che, a cominciare dal piacere di disegnarsi, reagisce e desidera. Ma la manifestazione del desiderio non è l’autogratificazione crumbiana, non è un gioco neutro della fantasia: è la battaglia quotidiana per la conquista della propria agentività, è una performance che si mette in scena pagina dopo pagina dentro e contro le condizioni sociali avverse. In questa incarnazione dell’autofiction disegnata, il corpo è un insieme di abilità, non ha confini precisi, è fragile e malleabile allo stesso tempo, e ogni sua parte – come ogni parte dello spazio che lo circonda – è suscettibile di rivolta.
Decorare, curare, mutare
Kominsky-Crumb, qui eletta a ideale capostipite, Gloeckner, Seda e Doucet si sono trovate nella necessità di inventare i modi per rappresentarsi e per rappresentare le donne nei fumetti. Le loro scelte – che comportano anche una ridefinizione dei concetti di bellezza, espressività corporea, presenza nello spazio – risultano ancora vitali e, soprattutto nel caso di Doucet, hanno influenzato generazioni di autrici e autori. Tuttavia, nel recente affermarsi dell’autobiografismo, si è visto con quanta facilità la rappresentazione si ricodifichi e lo stereotipo si riaffacci, così come la narrazione tenda a riadagiarsi nel convenzionale e nel consolatorio.
Ma infrangere le convenzioni e riportare il disegno alla propria originaria corporeità – sia liberandone l’istinto come Kominsky-Crumb o attraverso una più meditata strategia come Gloeckner – non è certo la sola via percorribile. C’è ad esempio quella di Lynda Barry (1956-), che, al pari di Chris Ware per quanto nettamente meno celebrata, esplora le forme e le funzioni della memoria nella narrativa disegnata. Barry ricostruisce il passato attraverso i suoi detriti in un gesto, reale e simbolico, di risarcimento della perdita e del dolore. Nella densità visiva di One! Hundred! Demons!, forse il suo libro più celebre, l’autorappresentazione è estroflessa verso gli oggetti, sparsa tra le cose: non può essere contenuta dal corpo, ma vive nella cura con cui sono dislocate le cose che tocca e ricorda.
O ancora, agli antipodi della brutalità espressiva di Kominsky-Crumb, c’è la tensione decorativa di Geneviève Castrée (1981-2016), disegnatrice e musicista, discendenza diretta della connazionale Julie Doucet. Castrée decora il segno nelle storie brevi – fatte di pause, ellissi, rime visive – e anche nell’autobiografico Susceptible, storia della sua crescita al fianco della madre dipendente dall’alcol e dalle droghe. E “decorazione” sembra il termine più adatto anche se poggia sul gradino più basso nella gerarchia delle arti occidentali, come qualcosa di alieno alla struttura e all’ipotetica essenza di un oggetto. La parola non indica qui l’orpello ornamentale, ma un consapevole e articolato atto di risignificazione del trauma. Anche se si pone il compito di curare le ferite del passato, l’autobiografismo di Castrée è coniugato al presente: privo di nostalgie, condanne o assoluzioni, procede con lo stupore dell’infanzia che racconta e punta a liberarsi del suo peso. Ma è prima il disegno che dà linfa alla storia, con le figure umane racchiuse da una linea netta, i gesti un po’ scomodi, marionette in cerca di una loro armonia. La linea vale come strumento di comprensione, nel senso che racchiude e aspira alla chiarezza, secondo la lezione di Hergé, e a una ricerca di bellezza nuova e da condividere. La stessa volontà coinvolge corpi, spazi e lettering: una calligrafia sottile che, come un parlare sottovoce, costringe il lettore ad avvicinarsi.
Ridefinire la bellezza e rivendicare la bellezza appaiono questioni sempre più centrali. Particolarmente emblematico è il caso della statunitense Tara Booth (1988-), artista che spazia dalla pittura al fumetto fino alla creazione di pattern da indossare e che dichiara programmaticamente l’intenzione terapeutica della sua creatività. L’autrice disegna se stessa ostentando una canonica bruttezza: sproporzionate le membra, goffe le posture, deformati i tratti del volto, mentre nelle storie, brevi tranches de vie, intimismo, comico e disagio quotidiano procedono abbracciati. Ma l’effetto è opposto, con la composizione e la vitalità del tratto che, al di là dell’evidente autoironia nel raccontare le angosce personali, comunicano vera gioia visiva e partecipazione. Soprattutto nel colore, Booth esalta le qualità terapeutiche della decorazione, riscontrabili nei risultati come nel processo: pattern costruiti strato dopo strato alla ricerca della giusta, singolarmente armonica, combinazione di forme e di toni.
Si può andare oltre. Lisa Hanawalt (1983-), autrice celebre se non altro per la collaborazione alla serie Bojack Horseman, ha portato ad un nuovo livello la tradizione zoomorfista del fumetto, facendone il campo di un’incessante oscillazione dell’identità. Nelle sue pagine – che slittano secondo necessità dal fumetto al racconto illustrato, dal fantastico puro al diarismo diretto – la trasmutazione fisica o nei comportamenti dall’umano all’animale si accompagna all’instabilità dello stile, in perenne fibrillazione tra il realismo e l’astratto. Per certi artisti l’ossessione è la sostanza dello stile, qualcosa di stabile che segna i confini della loro lingua e gli dà sapore e direzione. Per Hanawalt, il principio ordinatore è un interesse di tipo feticistico che si concentra sempre sul particolare – si tratti di storie, reportage, divagazioni, illustrazioni – assecondando, per parafrasare il titolo di una sua raccolta, uno sguardo sporco e scemo.
È, alla base, una ricerca del piacere, libera e non per questo meno attenta e politicamente responsabile. E la figura dell’autrice? Quando le capita di disegnare se stessa, Hanawalt lo fa sempre in maniera diversa, senza una sintesi, quasi con informale disinteresse, a meno che non scatti l’identificazione equina, la sua ossessione primaria: “dagli otto ai quattordici anni sono stata un cavallo”, “I cavalli sono il mio interesse principale”. Ma la sua non è una proiezione né una maschera o una metafora. è l’impronta del desiderio, come se Hanawalt volesse essere un cavallo.
Nel fumetto contemporaneo, più facilmente al di fuori dell’area del graphic novel, le modalità di rappresentazione del corpo finalmente sono esplose. Cadono, in particolare gli scarni ma rigidi codici che costringevano nello stereotipo i corpi delle donne, ma anche gli schemi di una rappresentazione binaria del sesso/genere. Nell’interzona dove convivono realismo e astrazione, il disegno è lo strumento perfetto per scompaginare i dualismi e, se ogni rottura del codice si presta a essere codificata, si crea lo spazio per nuove rotture.
La carrellata di autrici successive all’esperienza pionieristica di Aline Kominsky-Crumb vuole rendere conto di alcune di queste rotture e di un’epoca in cui ci si interroga in profondità sulle modalità della sua rappresentazione, sulle sue radici culturali e discriminanti, sulle sue conseguenze politiche ed esistenziali. La domanda non dovrebbe però riguardare il modo in cui si “devono” rappresentare i corpi sulla base di nuove e più inclusive categorie, anticamera di nuovi stereotipi, ma i modi in cui si “possono” rappresentare i corpi per impedirne la codifica, per aprire spazi sempre nuovi al nostro sguardo.
Alla domanda sulle influenze nel suo modo di disegnare le donne, Lale Westvind, geniale creatrice di mondi futuri e possibili, risponde: “Disegno le donne nel modo in cui vorrei fossero state disegnate nei fumetti quando ero bambina. Ero così invidiosa del modo in cui erano disegnati gli uomini. […] Soprattutto, forse perché sono più androgini, amavo i personaggi che avevano una testa di animale. Vedi, se hanno una testa di animale non sono ovviamente maschi o femmine” (Brian Nicholson, This Amazing Mechanism She Can Control With Her Mind: An Interview with Lale Westvind, tcj.com, agosto 2020).
Postilla
L’area geografica a cui si è fatto riferimento è limitata, con rare eccezioni, all’America del Nord. È stata certamente la scelta più facile, considerata la ricchezza del materiale disponibile, e forse la più adatta per cominciare a muoversi in un campo ancora poco esplorato. Bisogna nondimeno guardare altrove e, soprattutto con occhi diversi. Anche se autrici e lettrici si sono moltiplicate, il graphic novel “non-maschile” corre più di un rischio di essere ridotto a genere (letterario) a sé stante, confinato nella sua riserva… L’organizzazione della cultura, sovrapposta a quella della produzione, impedisce alle differenze di manifestarsi come dinamica vitale di possibilità volta per volta realizzate, servendosene invece come ulteriore occasione per diversificare i prodotti, costruire schemi, apporre etichette.
Bibliografia
– Tara Booth, How to Be Alive, Retrofit Comics, 2017
– Geneviève Castrée, Susceptible, Drawn & Quarterly, 2012
– Julie Doucet, Dirty Plotte: The Complete Julie Doucet, Drawn & Quarterly, 2018
– Phoebe Gloeckner, A Child’s Life and Other Stories, Frog Books, 1998 (ed. it. Vita da bambina, Topolin Edizioni, 1999 e Fernandel, 2007)
– Lisa Hanawalt, My Dirty Dumb Eyes, Drawn & Quarterly, 2013
– Aline Kominsky-Crumb, Love That Bunch, Fantagraphics, 1990 e Drawn & Quarterly, 2018
– Trina Robbins (a cura di), The Complete Wimmen’s Comix, Fantagraphics, 2016
– Dori Seda, Dori Stories, Last Gasp, 1999
– Lale Westvind, Grip, Perfectly Acceptable, 2020