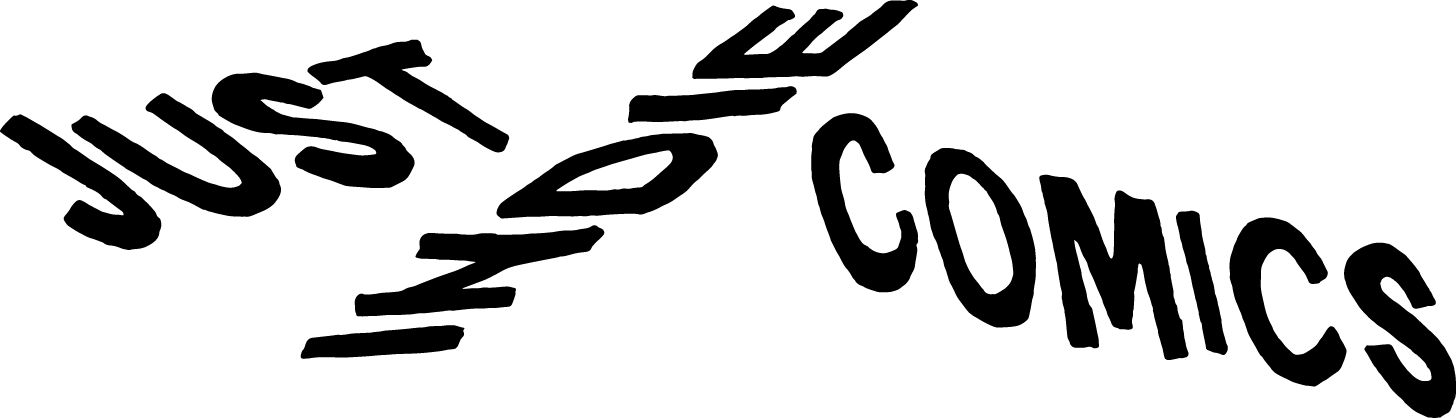Speciale “Hate” / Il titolo
Nel 1989 Bagge decide di chiudere l’avventura di Neat Stuff per dedicarsi a qualcosa di nuovo. E proprio Neat Stuff #15 fa capire dove sta andando a parare, dato che l’albo è interamente occupato da Buddy the Weasel, una lunga storia con protagonisti Buddy Bradley e Stinky. “Nel 1990 avevo finito di lavorare a Neat Stuff – scrive Bagge qualche anno dopo nello speciale Hate Jamboree – e volevo fare qualcosa nel classico formato comic book: una serie che si incentrasse su un personaggio principale ma che avesse l’aspetto e l’atmosfera dei fumetti underground della fine degli anni ‘60. Nel corso di Neat Stuff mi stavo interessando sempre di più alle storie dei Bradley, che erano basate in gran parte sulla mia famiglia, e a Buddy Bradley in particolare. Buddy era senz’altro il personaggio più autobiografico che avessi mai creato e, mentre pian piano ‘invecchiava’ nel corso di Neat Stuff, vedevo sempre più potenziale in lui come una fonte di idee per le mie storie. E quindi sceglierlo come protagonista della mia prossima serie fu una decisione facile da prendere”.
Ma come chiamare questa nuova serie, dunque? La prima idea di Bagge fu Love & Hate, ma il fatto che Fantagraphics pubblicasse già Love & Rockets dei fratelli Hernandez poteva creare un po’ di confusione. E fu così Kim Thompson, allora editore dell’etichetta di Seattle insieme a Gary Groth, a suggerire di chiamare il comic book semplicemente Hate: un titolo che piacque subito a tutti, anche se Bagge non si arrese a trovarne un altro. “L’unico problema – racconta ancora in Hate Jamboree – è che non riusciva a venirmi in mente niente di meglio, e infatti più pensavo al fatto di chiamarlo soltanto Hate più mi piaceva! E’ breve, è accattivante, è facile da ricordare… E sì, è il titolo più negativo che ti possa venire in mente – ha persino delle connotazioni neo-nazi, dato che il linguaggio della stampa mainstream lasciava sempre più intendere che soltanto la gente di estrema destra fosse capace di odiare qualcosa, come se il resto di noi non fosse in grado di nutrire sentimenti o emozioni d’odio. Mi ricordo anche di aver ascoltato un talk show in cui un ipocrita ‘leader spirituale’ new age sosteneva che gli anni ‘90 sarebbero stati una decade di ‘amore e comprensione’, rispetto agli anni ‘80 che erano stati caratterizzati da divisione, avidità, ecc. ecc. e che questo avrebbe portato a un’unione di tutti i popoli e di tutte le idee, così che saremmo potuti entrare nel nuovo millennio come una cosa sola e blah blah blah… Ovviamente, questo concetto di ‘pace e amore’ – ossia che tutti dovremmo essere d’accordo su tutto, e che quindi dovremmo essere d’accordo con questo tizio sdolcinato alla radio – era il concetto più spaventosamente fascista che io avessi mai sentito (e il tipo sarebbe poi diventato una sorta di ‘consulente spirituale’ dei Clinton), così capii proprio in quel momento che dovevo chiamare il mio fumetto Hate, in modo da dare il mio contributo affinché gli anni ‘90 non passassero alla storia come una ‘decade dell’amore’ molle e senza cervello”.
Qualche retroscena sulla nascita di Hate, e di conseguenza sul titolo della testata, è riportato in una storiella di sette pagine intitolata Prisoners of Hate Island! e pubblicata in appendice a Hate #1, in cui lo stesso Bagge pianifica insieme a Groth e Thompson la sua nuova avventura editoriale. E ovviamente prende in giro tutti, compreso se stesso.
A History of “Hate”
Era il 1990 quando Fantagraphics dava alle stampe il primo numero di Hate, l’allora nuova serie a fumetti di Peter Bagge. Trent’anni sono passati da quello storico #1, e per celebrare la ricorrenza la casa editrice di Seattle sta per riproporre tutti i 30 numeri del comic book e i successivi Annual in un elegante cofanetto in uscita il 24 novembre. Personalmente non ricordo quale fu il primo numero di Hate che comprai. Ciò che ricordo è che durante una vacanza-studio a Londra nell’estate del 1994 scappai dal British Museum dove il mio gruppo tornava per la seconda volta in pochi giorni e me ne andai da Gosh!, storico negozio di fumetti situato nelle vicinanze. Lì recuperai gli albi che mi mancavano delle mie serie preferite di allora, ossia Hate di Peter Bagge ed Eightball di Daniel Clowes, tornando dal Regno Unito con due collezioni finalmente complete. All’epoca, insieme al mio amico Giuseppe Marano, facevo una fanzine che si chiamava Underground e proprio a questi due autori avevamo dedicato il nostro #2 (in realtà era il terzo, perché c’era stato un numero zero secondo l’usanza di quegli anni). I due Comics Journal che utilizzammo come principali fonti per i nostri articoli, ossia il #154 (novembre 1992, dedicato a Clowes) e il #159 (maggio 1993, dedicato a Bagge), sono due delle pubblicazioni che ho letto e sfogliato più volte in vita mia. L’articolo su Peter Bagge portava la mia firma, e così devo constatare che a quasi trent’anni di distanza mi trovo di nuovo davanti a un computer a scrivere sugli stessi argomenti, non solo perché sono una persona monotona e noiosa ma anche perché Hate è una di quelle cose che non mi ha mai stancato e che mi sono sempre portato dietro nella vita. Ancora oggi questo fumetto mi fa ridere, mi intrattiene, mi appassiona e in una sola parola mi esalta per come racconta vicende così autentiche che nella mia testa sono diventate quasi vere: l’ho riletto di recente – tutti i 30 numeri, più gli speciali, più gli Annual – e non è invecchiato di un secondo, anzi, l’ho trovato più intelligente, ben fatto e divertente della gran parte dei fumetti che si pubblicano oggigiorno. E quindi non potevo non dedicargli un lungo tributo a trent’anni dalla nascita, perché se è vero che ci piace stare sempre sul pezzo, è anche vero che a volte siamo stanchi di novità. E allora è meglio concentrarci sulle nostre passioni più profonde. Sulle cose che restano.
Quello che leggerete di seguito è un lungo excursus sull’Hate di Peter Bagge, che ho cercato di rendere interessante sia per chi l’ha letto che per chi non ne ha mai sentito parlare prima. I lettori di vecchia data si divertiranno – spero – a ripercorre le gesta di Buddy Bradley e soci trovando lo spunto per riprendere in mano i vecchi comic book. Chi ha conosciuto Hate attraverso i vari tentativi di traduzione italiana (prima su Il Mensile del Fumetto, poi da parte di Phoenix e quindi Magic Press), avrà forse lo stimolo di andare a caccia delle storie inedite in Italia completando ciò che la traduzione non è riuscita a portare a termine. I neofiti, che magari avranno la tentazione di recuperare il pur costoso ($119.99) cofanetto, potranno comunque leggere l’articolo che segue: pur parlando dei personaggi e delle loro vicende, ho cercato infatti di non scendere troppo nel dettaglio delle trame, soprattutto quando mi sono avvicinato alla conclusione. Mi scuso dunque se gli “esperti” troveranno alcuni passaggi sbrigativi e superficiali, ma era l’unica soluzione per far sì che quest’articolo potesse essere letto da tutti e non solo da pochi appassionati.
I contenuti dedicati a Bagge non finiscono qui. Nelle prossime settimane troverete infatti altri post su Hate e dintorni che approfondiranno dettagli e curiosità su questa serie cult. Quindi bando alle ciance e vi lascio… ad altre ciance. Buona lettura.
Peter Bagge nasce nel 1957 a Peekskill, nello stato di New York, da genitori cattolici che si convertiranno presto all’alcool. Quattro fratelli, brutti voti a scuola, comincia a disegnare sin da bambino ispirato dal fratello maggiore Doug. Dopo il diploma passa da un lavoro a un altro e a metà degli anni ‘70 si trasferisce nella Grande Mela. Lì tenta la strada accademica, iscrivendosi alla School of Visual Arts. Il tentativo fallisce dopo soli tre trimestri, anche se quell’esperienza gli permette di conoscere la futura moglie Joanne Connelly. Intanto tenta la strada dell’illustrazione commerciale ma capisce ben presto che non fa per lui. E’ la fine degli anni ‘70 e a New York il punk domina su tutto il resto, tanto che l’arte, il fumetto e la moda ruotano spesso intorno a esso. Bagge inizia a pubblicare su riviste come High Times, The East Village Eye, WW3 Illustrated, Video Games, Stop e Screw: sono fumetti brevi, spesso pagine singole, a volte semplici strisce fatte per strappare una veloce risata al lettore. Nel frattempo entra in contatto con John Holmstrom, editor della rivista Punk nonché fumettista. Con lui, e insieme a J.D. King, Bruce Carleton e Ken Weiner, fonda la rivista Comical Funnies, di cui usciranno tre numeri tra il 1980 e il 1981. Con Weiner si autoproduce, nel 1982, l’albo The Wacky World of Peter Bagge and Ken Weiner. A quel punto l’estetica di Bagge è già definita, e se lo stile è ancora sporco e ben più underground di quanto apparirà verso la fine del decennio, i tratti distintivi sono già lì, su tutti le grandi bocche aperte e le espressioni caricaturali, sgraziate e costantemente incazzate dei personaggi – così esagerate che sembrano uscite da un cartoon di Tex Avery o della Warner Bros.
Innamorato dei fumetti di Robert Crumb, cerca e ottiene la pubblicazione su Weirdo, debuttando nel terzo numero con una storia realizzata insieme a Holmstrom, King e il fratello Doug. Crumb apprezza molto il lavoro di Bagge, in particolar modo su Martini Baton, una striscia nata in collaborazione con Dave Carrino. Gli propone così di diventare editor di Weirdo, ruolo che Bagge ricoprirà per due anni, dal #10 (estate 1984) al #17 (estate 1986), cercando di far coesistere nella sua gestione due generazioni di autori underground, quella di Zap Comix e la nuova scena che stava nascendo a New York. O meglio, una delle scene di New York, dato che Bagge aveva un occhio di riguardo per gli artisti come lui, più punk, satirici, sporchi e meno raffinati rispetto a quelli che negli stessi anni gravitavano intorno a Raw di Art Spiegelman. Crumb non è l’unico a vedere qualcosa in Bagge. Anche Kim Thompson e Gary Groth di Fantagraphics intuiscono le potenzialità del ragazzo e si fanno avanti proponendogli di dar vita a una testata tutta sua. Neat Stuff è uno spillato formato rivista che esordisce nel 1985 ed è il terreno in cui Bagge sviluppa tutti i suoi personaggi più riusciti, oltre che – almeno per me – una delle serie a fumetti più divertenti della storia. Ecco dunque Junior, Studs Kirby, Girly Girl & Chuckie-Boy, The Goon on the Moon, Chet and Bunny Leeway e soprattutto The Bradleys, una famiglia disfunzionale del New Jersey dai chiari riferimenti autobiografici che si era già vista su Comical Funnies, Stop e Weirdo. Tra i diversi componenti della famiglia Bradley, e cioè il padre Brad, la madre Betty e i figli Buddy, Babs e Butch, Bagge dedica pian piano più spazio a Harold detto Buddy, tanto che già alcune storie scritte in tempi non sospetti (si pensi a Rock’n’Roll Refugee pubblicato su Neat Stuff #3 del 1986) potrebbero essere a tutti gli effetti degli episodi della testata che sarà.
L’esperienza di Neat Stuff si conclude dopo 15 numeri e 5 anni densissimi, in cui Bagge continua a collaborare a riviste e antologie varie, facendo un’apparizione anche nella prima pubblicazione di sempre della Drawn & Quarterly, ossia il primo numero dell’omonima antologia. Nel 1990 Bagge, nonostante le vendite discrete, decide di cambiare aria. Neat Stuff chiude i battenti e nasce così Hate, una delle serie di maggior successo di sempre in casa Fantagraphics, che permetterà a Bagge di allargare il suo seguito al di fuori della ristretta cerchia del fumetto alternativo. Hate sviluppa proprio il personaggio di Buddy Bradley – un Andy Capp poco più che ventenne ma che ce l’ha già con il mondo intero – e ne segue il trasloco dalla costa Est alla costa Ovest degli Stati Uniti. La stessa traiettoria era stata percorsa qualche anno prima da Bagge – trasferitosi nei sobborghi di Seattle insieme alla moglie nel 1984 – e dalla stessa Fantagraphics, che sul finire del decennio abbandonò la sede di Los Angeles per spostarsi all’ombra dello Space Needle.
Insomma, è l’aprile del 1990 quando nei negozi di fumetti arriva Hate #1. La copertina raffigura Buddy su un gigantesco hot rod e mette subito in chiaro in che mondo ci troviamo, citando Ed “Big Daddy” Roth e tutta un’estetica americana che parte da Harvey Kurtzman e altri autori di Mad passando per Basil Wolverton e i weirdos alla Roth, fino ad approdare all’underground di Crumb e Gilbert Shelton. My Pad and Welcome to It riprende le vicende di Buddy da dove le avevamo lasciate in Buddy The Weasel, la lunga storia che occupava per intero Neat Stuff #15. Se lì Buddy se n’era andato a dormire in spiaggia pur di non stare con tutta la sua pazza famiglia, qui ci mostra il suo nuovo appartamento dall’altra parte degli Stati Uniti, raccontando come ci è arrivato. Dopo aver vissuto in case condivise – spesso con tanta, troppa gente dentro – a Brooklyn, Hoboken e Minneapolis, eccolo dunque a Seattle, anche se la vera destinazione sembrava essere la California. Vabbè, meglio di niente, anche perché in quel periodo tutti parlano della “wonderful” Seattle. Ma per Buddy, che proprio come suo padre è sempre incazzato e vede il lato negativo di ogni cosa (non a caso il fumetto si chiama Hate), Seattle “non è fantastica come dicono”, visto che “le persone si comportano in maniera così gentile ed educata che ti viene da chiederti cosa hanno da nascondere” ed “è diventata troppo affollata e inquinata”. Il rapporto con i coinquilini non migliora certo l’umore del protagonista. Leonard “Stinky” Brown, compagno d’avventure già apparso in Neat Stuff e che l’ha seguito sin dal New Jersey, è un dongiovanni fancazzista menefreghista e casinista, sempre con qualche affare “incredibile” tra le mani e pieno di idee campate in aria che raramente arrivano a realizzarsi. Se Stinky è estroverso al punto da andarsene spesso in giro per casa tutto nudo, anche in presenza di estranei e nonostante le verruche genitali, il suo esatto opposto è George Hamilton, ultimo componente del terzetto. Riservato, paranoico, intellettualoide ma quasi sempre intento a guardare programmi trash in tv, George è il classico nerd che non ha amici né fidanzate, anche perché è troppo impegnato a scrivere sproloqui su questioni come morte, disperazione esistenziale e purezza spirituale che pubblica sulle sue fanzine fotocopiate, come meglio apprenderemo in una storia dedicata tutta a lui su Hate #3. E oltretutto è nero, finalmente a dare un po’ di colore al mondo dannatamente white trash di Bagge.
Il centro di tutto è però, ovviamente, Buddy: un personaggio ispirato inizialmente al fratello più piccolo dell’autore, ma che con il passare del tempo diventa sempre più autobiografico, con qualche aspetto caratteriale preso in prestito da amici e conoscenti. Bagge, ormai ultratrentenne, sposato e con una figlia, si ispira per Hate alle esperienze personali vissute ai tempi di New York ma le colloca a Seattle, in modo da avere sempre a portata di mano una realistica scenografia. La scelta si rivelerà ancor più fortunata del previsto, perché di lì a poco – con il boom di Nirvana e Pearl Jam ad arricchire una scena musicale già animata da band come Soundgarden e Mudhoney – Seattle diventerà il centro del mondo e Bagge attirerà molti lettori proprio grazie all’ambientazione delle sue storie.
Con il secondo numero il cast si arricchisce dell’immancabile componente femminile, grazie all’arrivo di due personaggi chiave. La prima è Valerie, incontrata in una sala biliardo e che dimostra subito un certo interesse per il protagonista. Affascinante e determinata, è la classica tipa che Buddy sembra non meritarsi, anche perché – per quanto sia irritabile e astiosa – è evidentemente meno incasinata di tutti gli altri. E ha davvero un bel culo, come fa notare Bagge disegnandola con forme esageratamente sinuose mentre si china sul tavolo da biliardo in Hate #2.
Questo secondo numero è uno dei migliori – se non il migliore in assoluto – della serie e ha la struttura della tipica commedia romantica di Hollywood. Dopo aver litigato con un reduce dal Vietnam per aver chiamato lui e i suoi commilitoni “losers”, Buddy strappa un appuntamento a Valerie. Quando i due si rivedono le cose sembrano mettersi subito bene, dato che dopo una breve passeggiata la ragazza lo invita a casa rivolgendogli promettenti allusioni. Peccato che la coinquilina di Valerie sia Lisa, vecchia conoscenza del protagonista e in un certo senso anche dei lettori, dato che è la rielaborazione del personaggio femminile di Sometimes I Think I’m Going Crazy, storia breve apparsa sul #1 di Neat Stuff. Lisa aveva raccontato all’amica un’esperienza non proprio felice con un certo Buddy, reo di averle ficcato a forza la testa nella tazza del cesso durante un rapporto sessuale. E sì, si trattava proprio del nostro Buddy. Valerie, a cui non manca il carattere per farsi rispettare dagli uomini, va su tutte le furie e caccia via in malo modo l’aspirante spasimante. Ma in realtà si tratta solo di un rinvio, perché già alla fine di questo stesso episodio i due fanno pace spassandosela su un letto d’ospedale. Da qui inizia una tormentata relazione, caratterizzata da selvaggi litigi e passionali riappacificazioni, come Bagge ci racconta in Hate #3. Sempre nel #3 debuttano le rubriche, ciliegina sulla torta del comic book. Per ora ci sono soltanto gli editoriali e la pagina delle lettere, ma sono più che sufficienti. Se la pagina delle lettere è un divertentissimo ritrovo di fan e detrattori fuori di testa (ma di questo parlerò dettagliatamente in un prossimo post), gli editoriali diventano lo spazio in cui Bagge spara una raffica di segnalazioni di fumetti, fanzine e riviste, con i lettori che lo inondano di materiale cartaceo per farsi dedicare qualche riga. Rileggere tutto ciò diventa un modo per ripercorrere la storia dell’underground anni ‘90 USA come neanche la rete ci permette di fare, dato che molte delle pubblicazioni di cui si parla risalgono all’era pre-internet e non si trovano nemmeno con una ricerca Google.
Buddy è ormai stabilmente fidanzato con Valerie e fa il commesso in una libreria dell’usato, un mestiere che Bagge conosce bene dato che prima di diventare un cartoonist a tempo pieno aveva lavorato per più di tre anni alla Barnes & Noble della Penn Station a New York. Ma per lui la vita è tutt’altro che tranquilla e monotona, anzi, a volte è animata anche dai fantasmi del passato. Nel #4 torna infatti – direttamente dalle pagine di Neat Stuff – il fratello Butch, già militarista e patriottico da ragazzino e ora diventato un reazionario tout court, tanto da portare una maglietta recante bandiera americana e scritta “Try burning this, asshole!”. Come già nell’incontro con il veterano del #2, torna il tema politico: il protagonista, che in storie come Buddy the Weasel (Neat Stuff #15) aveva mostrato qualche accenno di razzismo, sembra diventato ormai aperto e progressista. E’ chiaro che l’emancipazione dal contesto familiare e suburbano gli ha giovato, come invece non è successo a Butch, che è andato via di casa soltanto per arruolarsi nell’esercito. Certo, non si può nemmeno dire che Buddy sia diventato questo grande pensatore né tantomeno un attivista, visto che il suo menefreghismo e un certo nichilismo di fondo hanno sempre il sopravvento su pensieri potenzialmente più elevati. E’ un numero tutto a tema familiare questo, con una breve storia di chiusura in cui scopriamo il destino della sorella Babs, una “versione molto più stupida” della sorella dell’autore. Ciò che ne viene fuori è che, se Buddy sembra incasinato, i suoi consanguinei non se la passano certo meglio tra gli umani orrori del New Jersey.
A questo punto Bagge ha presentato i personaggi e i temi ricorrenti della sua underground opera a fumetti. E per lui è davvero un gioco da ragazzi sviluppare il tutto nel suo tratteggiato e caricaturale bianco e nero, con i personaggi dalle grandi teste e dagli arti sottilissimi che inanellano espressioni e posture sempre più esagerate strappando sonore risate ai lettori. Le creature di Bagge spalancano la bocca, digrignano i denti, sudano, inorridiscono e si incazzano al punto che gli occhi gli escono fuori dalle orbite, il tutto senza soluzione di continuità, anzi spesso in un crescendo di situazioni comiche paradossali. I numeri che vanno dal 2 al 15 sono i migliori della serie per come uniscono realismo, dialoghi al fulmicotone, autentica antropologia culturale e uno spietato sense of humor che rende irresistibili storie di divertente quanto disperata quotidianità. Oltre a quelli già accennati, i momenti fondamentali sono la nuova appariscente capigliatura di Lisa (#5), la visita di Buddy e Valerie ai genitori di lei (#6) e l’improbabile appuntamento tra George e Lisa (#7). Discorso a parte meritano i numeri 8 e 9, che contengono Follow That Dream!, la storia di maggior successo di Hate, che spingerà la testata a quota 25.000 copie vendute. E non sono cifre da poco per un comic book del genere, che comincia a registrare un certo successo non tanto nelle fumetterie tradizionali quanto nelle librerie alternative e nei negozi di dischi, come Fallout Records, storico negozio di Seattle aperto tra il 1984 e il 2003, dove Hate vendeva centinaia di copie. Follow That Dream! è ambientata proprio nel mondo della musica ed è la storia che rappresenta il legame più concreto tra Hate e Seattle, perché se in altri frangenti la città del grunge è più che altro uno sfondo, qui è davvero la protagonista. Il motore della vicenda è l’ennesima idea balorda di Stinky, che in questo caso non si rivela così campata in aria. Sollecitato dall’amico, Buddy abbandona i panni del pigro e passivo slacker della Generazione X per prendere sotto la sua ala protettiva un gruppo di giovani musicisti capelloni e alcolizzati. Se il protagonista si trasforma così in un gretto manager discografico, il suo socio non è da meno, dato che scende direttamente sul palco con la band ribattezzata in suo onore Leonard and the Love Gods.
Il neo-manager si rimorchia anche una tipa in un negozio di dischi, portandosela a letto con la promessa di darle dei biglietti per il backstage. La scena – in cui la partner occasionale di Buddy si sdraia sul letto completamente disinteressata – testimonia la schiettezza di Bagge e un approccio ai temi sessuali diretto e senza fronzoli, tanto da venire duramente criticata dal pubblico, soprattutto femminile. Ma i detrattori forse non si erano ancora resi conto che, sin dai tempi di Neat Stuff, Bagge utilizza i suoi personaggi per mostrare, commentare e a volte criticare comportamenti e luoghi comuni. Se Crumb – e con lui Joe Matt, tanto per fare un altro esempio – mette in mostra se stesso e la sua fascinazione maniacale per il corpo femminile (e se c’è autocritica, compiacimento o un inscindibile mix di entrambi è questione complessa che merita altra sede), Bagge non fa fumetti esplicitamente autobiografici ma racconta le vicende di personaggi di fiction. I suoi fumetti diventano dunque un luogo dove – attraverso le gag, i paradossi, il disegno ipercaricaturale – si svolge un’analisi di temi sociali, relazionali e sessuali. Insomma, Buddy Bradley non si comporta come farebbe Peter Bagge, Buddy non è un personaggio positivo a tutto tondo né tantomeno il classico “eroe” dei fumetti, e Bagge non considera necessariamente “giusto” e “fico” tutto ciò che Buddy fa o dice. “Quando scrivo le mie storie – dirà Bagge qualche anno più tardi in un’intervista a Heidi MacDonald ristampata nel volume Peter Bagge: Conversations edito dalla University Press of Mississippi – non penso mai ‘Mi piace questo personaggio e voglio che a tutti piaccia questo personaggio e poi lo farò scontrare con un altro personaggio che rappresenta tutto ciò che non mi piace’. I personaggi non rappresentano idee o ideali. Sono solo persone. E tra le persone con cui ho a che fare non c’è nessuno che trovo assolutamente perfetto o del tutto insopportabile”. E anche Buddy è tutt’altro che perfetto, anzi, oltre ad approfittarsi delle fan della “sua” band tra un concerto e l’altro riesce anche a farsi sfuggire Valerie, mandando all’aria la relazione. D’altronde non gliene frega niente di niente, figuriamoci se si dà da fare per tenersi stretta la fidanzata.
Si aprono così le porte al prevedibile ritorno di fiamma tra Buddy e una Lisa oltre i limiti della disperazione esistenziale e dell’autocommiserazione, tanto da arrivare a indossare un sacco di patate (#10) e a farsi praticamente violentare da un Buddy di nuovo politicamente scorretto dopo essersi rimessa in sesto e in tiro (#11). Altra scena, questa, più crumbiana di Crumb stesso: facile pensare che se fosse stata concepita e pubblicata oggi, l’autore si sarebbe beccato critiche a non finire e l’editore sarebbe stato costretto a chiedere scusa a tutti per aver dato alle stampe il fumetto. Per Lisa i patimenti non finiscono qui tra l’altro, dato che sul finale dello stesso numero Buddy, sempre più incontenibilmente ed egoisticamente arrapato, finisce quasi per affogarla nella vasca da bagno durante un rapporto sessuale.
Nei numeri seguenti assistiamo al tentativo del protagonista di lanciarsi nel mercato del collezionismo partecipando a una fiera del settore (#12), alla misteriosa scomparsa di George, che ha descritto Buddy come esempio negativo della gioventù contemporanea in un numero della sua rivista Zygote stampato in migliaia di copie e distribuito in tutta Seattle (#13), al ritorno di Valerie (#14) e alla rivisitazione della storia che aveva aperto la serie (#15). Questa volta però nell’appartamento c’è decisamente troppa gente, dato che vi si ritrovano tutti insieme Buddy, Stinky, Lisa e anche i redivivi Valerie e George. Forse per il nostro è il momento giusto per cambiare un po’ aria e magari andare a trovare la famiglia nel New Jersey…
Ed eccoci ad Hate #16, numero storico che segna l’inizio della seconda metà della serie e l’inaspettato passaggio al colore, una svolta che Bagge aveva pensato da tempo e che è diventata economicamente possibile grazie alle ottime vendite. Inoltre scegliere il colore significa sveltire i tempi di lavorazione, rinunciando all’elaborato tratteggio in bianco e nero e al lavoro sulle chine, ora affidate a Jim Blanchard. Si passa così da tre a cinque uscite all’anno, e Bagge può finalmente vincere la frustrazione di dover rallentare i suoi plot per star dietro a tutti gli aspetti della produzione artistica. Ma inevitabilmente la scelta divide i lettori: a partire dal numero seguente si susseguono lettere su lettere che danno a Bagge del venduto, accusandolo di aver perso lo spirito underground degli esordi e di realizzare un fumetto ormai commerciale che non fa nemmeno più ridere come una volta. Se è vero che all’epoca Bagge si divertiva a pubblicare soprattutto le lettere di critica e insulti, tralasciando quelle di complimenti che riteneva spesso troppo noiose, c’è da dire che il nuovo Hate non convince tutti, e una frangia del pubblico – soprattutto quella più giovane – rimane delusa non solo per l’adozione di uno stile decisamente più pop ma anche per il cambiamento di temi e ambientazione. Una volta Hate era la serie underground in cui il pupillo di Robert Crumb raccontava in modo caustico l’altra faccia della Seattle del grunge, ora è invece diventata una colorata situation comedy ambientata nel New Jersey il cui protagonista si è stabilmente sistemato nel seminterrato dei genitori insieme alla fidanzata. Ed è anche il personaggio di Lisa a suscitare le inferocite reazioni del pubblico maschile, a cui bruciava vedere in Buddy il cagnetto al guinzaglio della partner rappresentato da Bagge nella copertina del #21, introdotta dallo strillo The Official Voice of “Sellout Nation”. Sì, perché nel frattempo su Hate è arrivato anche il codice a barre e, soprattutto, la pubblicità, inaugurata dalla quarta di copertina del #19 con la locandina del film Crumb di Terry Zwigoff e poi deflagrata definitivamente dal numero successivo con dischi, orologi, negozi, accendini e via dicendo. Bagge si giustifica nell’editoriale del #20 definendo questa soluzione come l’unica possibile per mantenere inalterato il prezzo di copertina a causa dell’aumento del costo della carta, ma ovviamente un buon numero di lettori si scaglia contro di lui, la Fantagraphics e chissà chi altro… Da segnalare che da Hate #20 le pagine da 24 diventano 32, anche se si passa da una lussuosa carta bianca a un’altra ben più economica.
Ma torniamo alla cosa che ci interessa di più, ossia storie & disegni. E’ vero che il nuovo Hate non è al livello del vecchio? Beh, anche io all’epoca rimasi piuttosto interdetto dal passaggio al colore, tanto che a neanche 18 anni sulle pagine del #5 di Underground rompevo le palle scrivendo che “la prima impressione è che la testata abbia perso un po’ del suo fascino underground”. Bleah, che maledetto e imberbe snob… Però ok, a riguardarli oggi i numeri in bianco e nero sono decisamente più belli di quelli a colori, e un po’ devo dare ragione al me stesso di allora che vergava tali sentenze dalla sua cameretta di Anzio con un Commodore 64. Ma va anche detto che il comic book migliorerà numero dopo numero, trovando giovamento dalla maggiore confidenza alle chine di Blanchard, dai colori che diventano via via più caldi e paradossalmente anche dalla carta più economica, utile a dare un aspetto più cheap e meno patinato al tutto. Per quanto riguarda le storie, il periodo che va dal #16 al #21 è quello più altalenante dal punto di vista qualitativo, con un accurato spaccato della vita nei sobborghi americani ma anche con qualche momento di stanca dovuto alla ripetitività di certe situazioni familiari. Sì, perché alla fine Buddy e Lisa si stabiliscono nel New Jersey e a Seattle non ci tornano più. Bagge corregge completamente il tiro e smette di raccontare la giovinezza, le bevute, le uscite con le ragazze, i rapporti con i coinquilini e passa a descrivere la vita familiare, ispirandosi al suo retaggio di gioventù – già così importante per The Bradleys – e al periodo di Redmond, nei sobborghi di Seattle, quando aveva messo su casa e famiglia con la moglie Joanne.
Ovviamente cambia anche il cast dei comprimari, che torna a grandi linee quello di Neat Stuff, con la madre e il padre di Buddy, il fratello Butch, la sorella Babs con i suoi scatenatissimi figli e il balordo ex marito Joel, il compagno di scuola Tom diventato poliziotto e altri amici e vicini che rientrano in scena dopo anni di limbo. Tra questi il più importante è Jay, con cui Buddy aveva già legato in Hippy House (Neat Stuff #9). I due se la intendono ancora e insieme mettono su un negozio di oggettistica, memorabilia, riviste e dischi, insomma un paradiso per nerd inaugurato nel #19 con il titolo B & J’s Collector Emporium. Intanto nel #18 Buddy si è comprato una macchina degna di un supereroe, la cosiddetta poliomobile, un hot rod deforme con ruote giganti davanti e normali dietro. Non può non tornare alla mente la copertina di Hate #1, che all’epoca non aveva niente a che fare con il contenuto di quell’albo ma che adesso suona quasi profetica. Dopo due storie in cui il nostro se la deve vedere prima con i nipoti (#20) e poi con le bizze del padre appena uscito dall’ospedale e capace di catalizzare l’attenzione di tutte le donne della casa (#21), dal #22 la musica cambia. Bagge comincia a spingere sull’acceleratore introducendo nelle sue storie elementi di realismo spietato, quasi dei pugni assestati alla pancia dei lettori che nel tempo avevano conosciuto e amato i suoi personaggi. Forse una reazione alle accuse di essersi venduto e addolcito? Forse sì, o forse sono cose che Bagge aveva già in testa da tempo. Fatto sta che da questo numero le risate diventano sempre più amare o cessano quasi del tutto, almeno in alcuni frangenti. Difficile a questo punto scendere nei dettagli, perché entriamo nel vivo della trama, e anticipare altri sviluppi rovinerebbe la sorpresa a chi non ha mai letto Hate. Evito dunque il racconto di questo #22 come anche del #23, un episodio chiave tutto incentrato su Lisa. E che dire del #27, altro momento di sconcertante realismo? Bagge dimostra in questa fase di non essere solo un umorista e un abile creatore di storie, ma anche di saper stupire il lettore e di metterlo a disagio raccontando situazioni drammatiche. E di delineare personaggi “veri”, come per esempio la stessa Lisa, non più la ragazza in bianco e nero dei primi numeri, depressa e sottomessa, ma un personaggio “a colori”, sfaccettato e capace di inaspettati colpi di testa.
La serie sta ora vivendo un momento d’oro, grazie a questi “slice of life” e a un Buddy tornato single, che non vive più in famiglia ma si accompagna – sempre e comunque malvolentieri – a una congrega di balordi composta dal fratello Butch, dal solito Jay, dal vicino Jimmy Foley, dall’ex cognato Joel e dall’ambiguo duo composto da Jake The Snake e Pencils. A respirare nuovo ossigeno sono sia i lettori che lo stesso protagonista, ormai stabilitosi nel retro del suo negozio e pronto a sperimentare di nuovo la magia degli appuntamenti e dei flirt occasionali, arrivando a incontrare addirittura tre donne in un solo episodio, The Single Life appunto, pubblicato su Hate #29. La mutazione è ormai compiuta e, dopo qualche incertezza iniziale nella fase di passaggio, Hate si è egregiamente trasformato in un fumetto che descrive l’altra faccia dell’american way of life, o la vera vita dei sobborghi americani. Bagge non vuole raccontare storie eccezionali di personaggi speciali, perché ciò che gli interessa è la quotidianità, le piccole situazioni che tutti ci troviamo ad affrontare. E le disegna senza sentirsi superiore ai suoi personaggi, anzi, sentendosi proprio uno di loro.
E siamo arrivati quasi alla fine, in numeri sempre più densi di contenuti, anche a firma di altri autori. Se dal #21 ci aveva pensato l’irresistibile Doofus di Rick Altergott a riempire qualche pagina in eccesso, una nuova rivoluzione si era sviluppata dal #26, con l’upgrade a 48 ricchissime pagine contenenti contributi di altri cartoonist, rubriche dei fanzinari recensiti da Bagge nel corso degli anni e ovviamente altra pubblicità. Ma di questo leggerete in un prossimo articolo, ora torniamo appunto a Hate #29, che al momento dell’uscita sembrava un numero qualsiasi. Niente lasciava presagire che il #30 sarebbe stato quello finale e invece ecco qui che questo corposo comic book di 56 pagine uscito a giugno del 1998 (con il prezzo stavolta rialzato a $3.95, tanto è l’ultimo numero e nessuno può protestare) conclude di botto le vicende di Buddy Bradley e soci. L’appena quarantenne Bagge si diverte a disegnare se stesso mentre tiene in mano un mini Buddy Bradley e lo butta nella tazza del cesso urlando “Say goodbye, folks!”. E aggiunge nell’editoriale: “Yes, this is the last issue of HATE. Why? Well, I, uh… Jeez, that’s a good question… Because I’m a SELF-DESTRUCTIVE FOOL, that’s why!”. E in effetti lasciare una serie che stava sperimentando un successo di pubblico davvero insolito per un fumetto “alternativo” sembrava una mossa suicida, ma Bagge voleva cambiare aria e dedicarsi a qualcosa di diverso, chiudendo i battenti quando il successo era ancora dalla sua e non per un calo di vendite o per mancanza di interesse del pubblico. Lo stesso era successo quasi dieci anni prima con Neat Stuff, chiusa all’improvviso per cercare vie alternative. Per quanto riguarda la storia del #30 beh, non posso certo raccontarvi come va a finire, quindi mi limito a dire che si assiste al ritorno di vecchi amici e che ci sono un paio di colpi di scena da ricordare… Oltre al fatto che alla fine Buddy trova il “fischietto magico” che era stato suggerito a Bagge dal fumettista Sam Henderson nella pagina delle lettere di Hate #12 e che era diventato un tormentone tra i lettori. Niente male come dedica finale ai super-appassionati che hanno seguito la serie per otto anni e che devono dire addio a personaggi amatissimi, che sono diventati quasi degli amici, come succede di solito con i migliori telefilm.
In realtà Hate #30 non segna la fine delle vicende di Buddy Bradley. Il 1998 vede l’uscita, oltre che di un’intervista sul #206 di The Comics Journal con copertina a tema The Death of Hate!, di uno speciale celebrativo intitolato Hate Jamboree. Quest’ultimo è un magazine di 64 pagine in cui Bagge celebra la fine delle avventure di Buddy Bradley. Anzi, più che una rivista la potremmo chiamare una fanzine, nel senso di un prodotto per i fan più che fatto dai fan. Il tono è chiaro sin dalla copertina, e basta aprire l’albetto per ritrovarsi, a pagg. 2 e 3, una splash page con un Buddy stupito che viene salutato dai suoi comprimari e anche da persone “reali” come lo stesso Bagge e Gary Groth. Il cuore di Hate Jamboree è il lungo articolo Hate: A Love Story, in cui lo stesso Bagge racconta genesi, storia e curiosità del suo comic book in 13 pagine accompagnate da illustrazioni spesso rare o inedite. Tra queste copertine (Screw, The Rocket, The Stranger, Goldmine), vignette tratte da Weirdo, High Times, Spin e altre riviste, poster per concerti e tour come l’HateBall del 1993 che vide il nostro girare le fumetterie statunitensi insieme a Daniel Clowes. Per il resto l’albetto è occupato da tributi, interviste a compagni di viaggio come Jim Blanchard e Rick Altergott, un’accurata bibliografia e fumetti rari dello stesso Bagge, tra cui cito come esempi più significativi la collaborazione Bagge-Clowes vista su Cracked #220 del 1986, un’illustrazione tratta da Honk #2 (ancora 1986, Fantagraphics) che accompagnava uno scritto di Alan Moore, la riproduzione integrale di un fumetto inchiostrato da Jim Woodring e realizzato per il booklet di un CD di George Thorogood, alcune strisce inedite di Studs Kirby pensate per la rivista del canale televisivo ESPN e mai pubblicate.
Ma questa grande festa di addio si rivelerà invece un arrivederci, dato che un paio d’anni dopo Bagge non resisterà alla tentazione di riportare sulla pagina le sue creature iniziando la pubblicazione degli Hate Annual. Proprio sugli Annual, e su altre curiosità legate a Hate, tornerò in una serie di approfondimenti che troveranno presto spazio su queste stesse frequenze. See you in the next post!
Dagli archivi: “Kramers Ergot” #4
Nel post precedente della rubrica “Dagli archivi” avevamo lasciato Sammy Harkham alle prese con Kramers Ergot #3, prima vera antologia formato libro dopo le prove generali dei primi due numeri. Tra il #3 e il #4 del magazine passò soltanto un anno ma in mezzo sembra ci sia stata una rivoluzione, perché quando nel 2003 uscì il nuovo numero di Kramers, ancora autoprodotto con il marchio Avodah Books, arrivò sugli scaffali delle più lungimiranti fumetterie statunitensi uno dei libri più importanti che la storia del fumetto alternativo ricordi. Kramers #4 è imponente e anche stupefacente, perché è cosa rara vedere un ragazzo di 23 anni autoprodursi un tomo di 330 pagine in grande formato e per giunta a colori in grado di contenere il meglio dell’indie e dell’underground nord-americano, pescando parimenti tra nomi noti e meno noti. Di sicuro Harkham aveva un po’ di soldi da parte, per decidere di stampare 2500 copie di un volume brossurato 22 x 27 cm affrontando i rischi di un possibile flop sul mercato. E in effetti, come racconta lo stesso editor in un’intervista pubblicata nel #2 della fanzine Bubbles, i primi ordini arrivati tramite Diamond alla Alternative Comics, che curava la distribuzione, furono davvero scarsi: soltanto 300 copie. Ma la situazione ebbe una brusca inversione di rotta con un tour nei negozi di fumetti e nei festival, culminato con una puntata al Mocca di New York, dove “vendemmo in media una copia al minuto”, racconta ancora Harkham. Da lì il passaparola, gli altri ordini ed ecco qui che Kramers Ergot #4 uscì ben presto dalla circolazione, nonostante una tiratura tutt’altro che limitata. Oggi l’antologia è un pezzo raro, difficile da trovare, e con cifre che si aggirano solitamente intorno ai 300 dollari.
Ma insomma, perché tanto clamore? La risposta la affidiamo allo stesso Harkham, che racconta la genesi del volume in questo video su YouTube: “Era il 2002 e in quel periodo c’era tantissimo materiale interessante in giro, soprattutto proveniente dall’area di Providence, ma nessun editore come Fantagraphics o Drawn & Quarterly poteva guardare a tutta quella roba, e così pensai che se fossi riuscito a metterla in un unico libro utilizzando anche il colore e dando spazio a ogni artista per pubblicare non solo fumetti ma anche sketchbook, collage e altre cose, beh, sarebbe stata una cosa eccitante anche come lettore”. Mi sembrano due gli elementi chiave di questa riflessione. Il primo è quello di attingere alla scena di Providence post Fort Thunder, i cui autori si erano già visti in qualche antologia ma che all’epoca era nel complesso poco conosciuta. Il secondo è invece il colore, un fattore che sicuramente ebbe il suo peso per strappare il sì a diversi autori, stuzzicati dall’idea di veder stampato il proprio lavoro in una forma diversa dal bianco e nero solitamente usato nei circuiti alternativi e underground.
Veniamo dunque i nomi coinvolti, in ordine di apparizione: Anders Nilsen, David Lasky, Renée French, Lauren Weinstein, Marc Bell, John Hankiewicz, Mat Brinkman (autore anche della “wraparound cover”), Ron Regé Jr., lo stesso Sammy Harkham, Jim Drain, Ben Jones, Dave Kiersh, C.F., Stefan Gruber, Joe Grillo, Josh Simmons, David Heatley, Souther Salazar, Geneviève Castrée, Allison Cole, Leif Goldberg, Tobias Schalken, Jeffrey Brown, Billy & Laura Grant. Fumetti, illustrazioni e sketchbook si susseguono senza soluzione di continuità, tanto che è compito del lettore capire dove finisce il contributo di un autore e dove ne inizia un altro. Il sommario, riccamente illustrato e che fornisce una sorta di introduzione ai contenuti veri e propri, elenca infatti gli artisti in ordine di apparizione ma senza dare indicazione su quali pagine siano occupate da ciascuno di loro. E d’altronde le pagine non sono nemmeno numerate. L’intento di Harkham sembrava essere, almeno in questo numero della sua antologia, non tanto quello di dare un’idea di omogeneità, quanto di creare uno spazio di sperimentazione continua, mostrando tutte le possibili declinazioni del fumetto “altro” (e quindi non seriale, non di genere, ecc.) agli inizi del terzo millennio.
Difficile citare soltanto qualche contributo tra tutti. Sfogliato di nuovo oggi, a 16 anni dalla pubblicazione, Kramers #4 risulta ancora sperimentale, geniale, all’avanguardia, a volte toccante, altre dissacrante, comunque ricco di spunti. Certo, nel 2003 aveva probabilmente una carica rivoluzionaria che oggi ha in parte perso, dato che ci siamo in qualche modo abituati a certo fumetto: si pensi per esempio a buona parte del catalogo PictureBox, di cui questo volume potrebbe essere considerato una sorta di preview. Ma se proprio devo fare una scelta, il primo autore che mi viene in mente è proprio Sammy Harkham, perché qui ammiriamo per la prima volta tutta la sua bravura. E’ su Kramers Ergot #4 che è stata originariamente pubblicato il suo capolavoro Poor Sailor (in Italia visto prima su Black #7 e poi su Golem Stories, entrambi usciti per Coconino), una drammatica e amara storia di 34 pagine su un uomo che si allontana dalla sua nuova casa e soprattutto dalla moglie per fare il marinaio. Lo definivo qualche anno fa un racconto “caratterizzato da pochi dialoghi e uno stile grafico da strip alla Popeye, su cui Harkham inserisce esplosioni di realismo e violenza”, in quello che era il primo post in assoluto del blog di Just Indie Comics. Oppure si potrebbe descrivere come una canzone di Will Oldham a fumetti, per la capacità di unire uno stile apparentemente classico a dei contenuti spigolosi, amari, crudi, citando tra l’altro un musicista che Harkham stima da sempre e per cui ha realizzato anche copertine di dischi.
Altro pezzo forte sono i due racconti di Anders Nilsen che rileggono il mito di Sisifo, le 24 pagine – praticamente un intero comic book – a firma Marc Bell, le 11 tavole a colori di schizzi e disegni di Mat Brinkman, 21 pagine di C.F. contenenti una storia breve e illustrazioni dai suoi sketchbook, l’incredibile lavoro grafico di Joe Grillo, le illustrazioni di un Leif Goldberg in stato di grazia e poi eccetera eccetera eccetera fino alla collezione di cover scartate che chiude il tutto. E qui chiudo anche io, augurandovi di avere già Kramers Ergot #4 nella vostra libreria o, in caso contrario, di riuscirlo a trovare in giro prima o poi.
Dagli archivi: “Kramers Ergot” #1-3
Con questo post iniziamo a dare un’occhiata a qualche fumetto fondamentale del passato, sperando di avere tempo, voglia e forza di portare avanti questa lodevole – me lo dico da solo – iniziativa. Come anticipato qualche tempo fa presentando la nuova “linea editoriale” di Just Indie Comics, non saranno analisi dettagliate, ma solo delle schede che avranno lo scopo di ripescare alcune “pietre miliari” o delle “chicche” uscite ormai da qualche anno. Cominciamo ripercorrendo le varie incarnazioni dell’antologia Kramers Ergot, fondata e curata dal cartoonist Sammy Harkham, e che nel corso degli anni ha cambiato filosofia, formato, editori, facendo la storia del fumetto alternativo americano del terzo millennio.
In realtà i primi numeri di Kramers non sono quelli arrivati fino a noi, dato che questo curioso titolo era già stato utilizzato per una delle fanzine fotocopiate prodotte da Harkham durante gli anni del liceo, alcune in Australia (dove la famiglia dell’autore si era trasferita per un periodo), altre al ritorno a Los Angeles insieme appunto a David Kramer. Oltre che al cognome del socio, che poi condividerà con Harkham anche l’avventura della libreria Family di Los Angeles, il titolo era ispirato alla canzone Ergot dei Big Black, dall’album Songs About Fucking del 1987. Le fanzine contenevano disegni, fumetti di amici, contenuti “rubati” da altre fonti e tante interviste a band e musicisti, tra cui Will Oldham. Il primo Kramers Ergot “ufficiale” risale invece al 2000 ed è ancora autoprodotto da Harkham sotto la sigla Avodah Books. L’albetto – formato 18 x 24 cm, spillato e di sole 48 pagine – ha poco in comune con quanto si vedrà in seguito, soprattutto a partire dal #4. Harkham, classe 1980, è giovanissimo e il suo stile è ancora immaturo, in più i fumettisti coinvolti sono tutti suoi amici o conoscenti: è il caso di David Brooke, compagno di scuola dei tempi dell’Australia, Justin Howe, un amico del fratello, e Luke Quigley, collega al California Institute of the Arts nella classe di animazione sperimentale. Quigley firma anche la cover del secondo numero, che replica del tutto formato e foliazione del precedente.
Diciamolo chiaramente, non succede niente di particolarmente eccitante in questi primi due numeri. Il materiale è ancora acerbo e la selezione inevitabilmente eterogenea e parziale. La curiosità va rivolta dunque soprattutto alle prime prove di un giovane Harkham, molto diverso dal cartoonist definito e consapevole che cominceremo a vedere a partire da Poor Sailor. Si tratta di un autore che non ha ancora assorbito la lezione dei classici come Roy Crane e Frank King, fondamentali per il futuro sviluppo del segno. Qui i riferimenti sembrano essere per lo più il Dave McKean di Cages o l’Al Columbia di The Biologic Show, che vengono alla mente guardando la storia di una pagina A Wound is an Inherently Disruptive Force o anche il primo capitolo di Where The Sun Still Shines, storia in due puntate che occupa ben 43 pagine tra Kramers #1 e #2, rimandando con le sue atmosfere metropolitane tra il noir e il grottesco al Metropol di Ted McKeever, con qualche eco del Mazzucchelli di Rubber Blanket. Lo stile del giovane Harkham è spesso incerto, a volte caotico e ricco di linee, altre più pulito e ordinato, oscillando inoltre tra una ricerca del realismo e i primi tentativi di rappresentazione simbolica della realtà attraverso gli strumenti tipici delle strip a fumetti. In tal senso gli episodi che lasciano presagire i prossimi interessantissimi sviluppi sono Hearing is not Enough (tre pagine da Kramers #1) e il secondo capitolo di Where The Sun Still Shines, che comincia a far vedere un tratto più rotondo e pulito.
Kramers #3 mantiene le stesse dimensioni 18 x 24 dei precedenti ma aumenta la foliazione a 128 pagine introducendo di conseguenza la brossura. Si tratta senza ombra di dubbio del numero più riuscito di questo primo lotto, in cui si vedono i prodromi dell’antologia che sarà. Harkham non pesca più tra conoscenze e amicizie, ma mette in moto la sua proverbiale curiosità per cercare quanto di più interessante si muove nel sottobosco statunitense, coinvolgendo nomi oggi ben conosciuti come Anders Nilsen (con gli assurdi e divertenti dialoghi tra Birds) e Hans Rickheit (quest’ultimo arrivato anche in Italia via Eris con The Squirrel Machine). La nota più importante è però il debutto di autori sperimentali come Ben Jones e Joe Grillo, legati alla scena Fort Thunder/Paper Radio/Paper Rodeo, da cui Harkham attingerà a piene mani per il numero successivo. Oltre a questi appena citati, nel volume troviamo Mark Burrier, Stefen Gruber, Kathleen Lolley, Neil Fitzpatrick, Zack Soto, Sara Varon, Luke Quigley, Mat Tait. Conclude il libro lo stesso editor con le 13 pagine di The Last Laugh, l’ennesima storia dell’amante illuso (e deluso) che è una costante delle sue primissime produzioni, caratterizzata da uno stile finalmente neoclassico, più vicino a quello con cui lo identifichiamo ancora oggi.
E per ora è tutto. A risentirci tra qualche giorno, settimana, mese o chissà con un altro episodio della rubrica Dagli archivi, in cui si parlerà di Kramers Ergot #4.