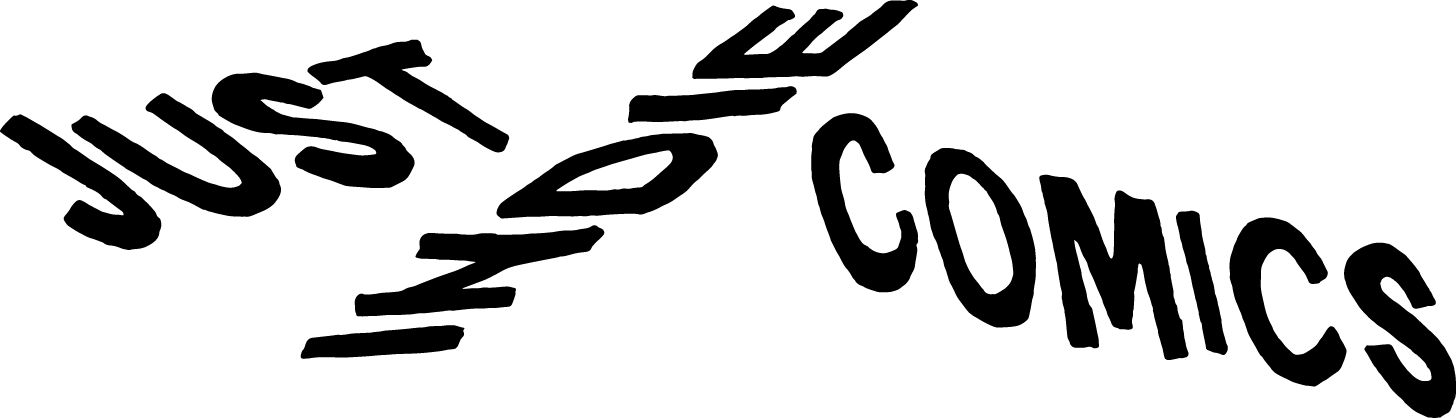Nuova puntata di Misunderstanding Comics, rubrica che si occupa di letture varie senza necessariamente parlarne con dovizia di particolari. Dato che siamo stanchi di novità, colgo l’occasione per recuperare qualche fumetto non proprio recentissimo.
I Never Promised You a Rose Garden è una serie a firma Annie Murphy di cui al momento sono stati pubblicati due soli numeri. La Murphy, classe 1978, è attivista queer, diplomata del Center for Cartoon Studies, autrice di una biografia di Achsa Sprague, curatrice dell’antologia Gay Genius e molto altro ancora. A vederli on line gli altri suoi fumetti sembrano più ordinari rispetto a questo, una cronaca politica e culturale incentrata sulla sua città, Portland. E anzi, I Never Promised non è nemmeno un fumetto nel senso più tradizionale del termine, dato che si tratta in realtà di un saggio illustrato, un quaderno in cui immagini sporche di inchiostro e dalle linee tremolanti si uniscono a lunghi testi trascritti a mano nella più idiosincratica tradizione del do-it-yourself.
Il primo numero, intitolato My Own Private Portland, si apre con la morte di River Phoenix e si sofferma inizialmente sulla carriera dell’attore, per arrivare ben presto alla genesi e all’analisi di My Own Private Idaho, ricca di interessanti retroscena. La Murphy descrive con abilità il clima culturale di quegli anni, la fine degli ’80, le storie di ragazzi di strada, prostituti, tossicomani che in alcuni casi avevano frequentato lo stesso liceo dell’autrice e da cui Van Sant rimase affascinato al punto da mescolarsi a loro nel quotidiano. L’eroina ha una parte importante in queste pagine, ed è solo uno dei tanti aspetti che ci fanno capire, come suggerisce il titolo, che almeno all’epoca la cosiddetta “City of the Roses” non era quella terra promessa che noi europei siamo soliti immaginare. Il primo numero si conclude con un parallelismo tra Phoenix e Kurt Cobain, ripreso senza soluzione di continuità nel secondo, in cui viene approfondita la biografia personale dell’attore e in particolare la sua educazione nella setta Children of God, dove gli abusi sessuali sui minori erano all’ordine del giorno. Murphy non risparmia nessuno, sviscera temi, fa domande, mettendo in dubbio anche l’operato di Van Sant, tacciato di “hispter racism”. Da lì si passa alla parte più politica del racconto, una rappresentazione critica del Pacific Northwest che si sofferma stavolta sui rigurgiti razzisti di una zona per tradizione tutt’altro che multietnica, come testimonia l’assassinio di Mulugeta Serraw, membro della comunità etiope di Portland ucciso nel 1988 da tre skinhead. Tra questi Kenneth “Ken Death” Mieske, personaggio noto nell’underground di strada della città dell’Oregon e fonte di ispirazione per Drugstore Cowboy. L’eco di quel fatto portò anche al processo contro Tom Metzger, militante razzista fondatore della White Aryan Resistance, documentato nell’ultima parte dello spillato.
Avrete capito a questo punto la densità dei fatti raccontati dall’autrice con scrittura piena, consapevole, dettagliata, appassionante ma mai eccessiva. La messa in scena trasuda spontaneità e ben si adatta a disegni che descrivono e a volte commentano con tono sardonico, come cartoline di un artista di strada disegnate sul momento, senza ripensamenti o rifiniture di troppo. Purtroppo non si hanno notizie se mai si vedrà un terzo numero, dato che l’ultimo risale al 2016 e che il blog dell’autrice è fermo allo stesso anno. Magari se mi decido a mandarle una mail scoprirò se questo piccolo gioiello nascosto avrà prima o poi un seguito.
Cambiamo totalmente mondo e passiamo a un autore che ha fatto del disegno – e che disegno – la sua peculiarità, dando forma a fumetti che difficilmente possono essere tradotti in soggetto, trama o semplicemente parole. Sto parlando di Walker Tate, cartoonist di Los Angeles abile nello scomporre pagine e vignette, a tracciare inusuali prospettive, ad accanirsi sui corpi con piglio cubista seppur con una linea pulita e tondeggiante. C’è qualcosa nelle sue creazioni, finora tutti comic-book autoprodotti autoconclusivi e di poche pagine, che ricorda Ruppert & Mulot, anche se non saprei dire se si tratta di un’influenza o di affinità elettiva. Del 2015 sono Waiting Room, rappresentazione di una sala d’attesa e degli oggetti che la abitano, ed Extract, storia paradossale di un uomo che decide di dividere il suo appartamento in tante porzioni diverse in modo da poterle affittare. Channel, del 2016, seguiva invece le evoluzioni di una pallina da golf. In tutti e tre i casi la trama – se così vogliamo chiamarla – era una scusa per dar vita a virtuosismi stilistici di ogni tipo, come le prospettive in movimento di Waiting Room e le scomposizioni di Extract, che interessavano prima l’appartamento (e di conseguenza la pagina) e poi il corpo del protagonista.
Ma è il più recente Procedural, uscito lo scorso anno, a cambiare le carte in tavola. I dialoghi stavolta hanno una parte importante nello sviluppo del racconto, le vignette sono regolari, il paradosso che prima ero per lo più visivo viene sviluppato in chiave narrativa. Un idraulico viene chiamato a fermare una perdita d’acqua proveniente dal soffitto, che ha costretto il proprietario di casa a portare il suo divano in un deposito. Lasciato a lavorare da solo, l’idraulico si accanisce contro la perdita senza successo, mentre il suo cliente non riesce più a trovare il divano, spostato di luogo in luogo per motivi sempre più assurdi. Nel frattempo un corriere deve consegnare delle confezioni di trota sott’olio… Lo so che detto così sembra puro nonsense, o un film di Alain Resnais, ma vi assicuro che Procedural funziona e lascia la curiosità di vedere che cosa si inventerà Tate la prossima volta.
Altra autrice che prosegue indefessa la sua ricerca stilistica è Lale Westvind, di cui avevo parlato brevemente qui in occasione del suo Hax uscito per Breakdown Press. I suoi fumetti meriterebbero ben altra attenzione di quella che gli sto dedicando io su Just Indie Comics e prima o poi sono convinto che riuscirò a parlarne meglio, magari insieme a lei. Qui mi limito a segnalare l’uscita del quarto numero di Hot Dog Beach, che trovo particolarmente interessante per una serie di motivi. Se infatti negli albi autoconclusivi e nelle storie per le antologie la Westvind adotta uno stile letterario denso e complesso, in cui il testo è spesso avvicinato all’immagine come descrizione, delirio, puro lirismo, in questa serie aperiodica autoprodotta troviamo invece uno stile più cartoon e dei dialoghi che spesso scelgono le vie della commedia.
Sia chiaro che le tematiche ricorrenti della Westvind – velocità, dinamismo, interazioni tra uomo e macchina, visioni lisergiche – rimangono costanti ma questa volta più che dalle parti di un futurismo cyberpunk siamo in un mondo alla Mad Max, con personaggi che si rincorrono senza ben sapere il perché verso la spiaggia del titolo. Ma la cosa che a me più interessa in questi quattro numeri qui è il modo in cui sono realizzati, ossia con un approccio spontaneo che non ha alle spalle una precisa pianificazione, una trama liquida che si può prendere da qualsiasi punto senza aver necessariamente letto il resto, i disegni che cambiano di volta in volta stile (e non potrebbe essere altrimenti, dato che il primo numero è datato 2010 e l’ultimo è dell’anno scorso). Anche la storia si evolve, inizia in un modo e prosegue in un altro, accelera, rallenta, riparte, prende deviazioni, tanto che probabilmente potrebbe durare all’infinito, soprattutto se l’autrice continuerà a costellarla di momenti visionari come le due spettacolari sequenze onirico-psichedeliche di questa quarta uscita. Hot Dog Beach ci riporta ai tempi in cui i fumetti non erano una cosa così seria e si poteva anche decidere di pubblicare qualcosa a puntate senza preoccuparsi della futura raccolta in volume. Ed è per questo una vera boccata di ossigeno.
Concludiamo con un’altra donna, se così si può dire, dato che Laura Pallmall è in realtà lo pseudonimo di Jason Lee, cartoonist (e non solo) trasferitosi di recente da Los Angeles – che rimane comunque lo scenario di riferimento dei suoi fumetti – a Pittsburgh. Lee pubblica da qualche tempo la serie di fanzine Nothing Left to Learn, caratterizzate dall’approccio do-it-yourself e dalla libertà con cui vengono messi insieme saggi, fiction, illustrazioni, poesie e ovviamente fumetti, come testimonia l’omonimo Tumblr. Nell’ambito del progetto ha trovato spazio anche una sotto-serie chiamata Sporgo e attribuita a tale Laura Pallmall, di cui sono usciti due numeri “rilegati” con l’elastico e caratterizzati da un tratto crudo, a volte sin troppo elementare nella sua semplicità, e da una divisione della tavola regolare.
Sporgo #1 si apre con Picaresque, realizzato per la Comics Workbook Composition Competition del 2015 e scelto tra i migliori fumetti dell’anno nell’ultima edizione di The Best American Comics, 16 pagine che rappresentano al momento il vertice dell’ancora limitata produzione dell’autore/autrice. L’apertura è un sogno dai contorni horror, che ci cala subito in un’atmosfera plumbea, oppressiva, angosciante. A pagina 2 un uomo viene svegliato dal suono del campanello, è un suo amico che è andato a trovarlo. Dal dialogo tra i due capiamo che il protagonista riempie le sue giornate di nulla, impegnato più che altro a comprare il cibo e a preparare i pasti per i vicini, che hanno deciso di passare la luna di miele chiusi in casa per smettere di fumare. Fuori le strade sono deserte, c’è solo un opossum sdraiato sul marciapiede che si dà per morto, oppure che è morto davvero. Doveva piovere quel giorno ma il sole continua a splendere. Forse prima o poi succederà qualcosa ma intanto si sta buttati sul divano o in strada, mentre si avvicina la notte. Non vi racconto tutto tutto anche perché c’è poco da raccontare ma il nulla di cui è fatta questa piccola riuscitissima storia risuona nella mente del lettore e lo avvolge in una spirale di inchiostro sempre più nera fino al suo notturno finale. E un’ombra nera, stavolta in senso non metaforico, è protagonista di From Eden to Hill, secondo racconto dell’albo, una ghost story meno efficace della precedente e che per trasmettere inquietudine sceglie strade non così originali. Eppure l’assonanza di temi e situazioni dà unità al tutto creando un corpus unico. Sporgo #2, pubblicato nel 2017 a due anni di distanza dal precedente, non si allontana molto da queste coordinate e segna l’inizio di una storia lunga intitolata Pyramid Inch, incentrata su un giovane filmmaker impegnato a scrivere sceneggiature puntualmente lasciate a metà. Anche qui mare, palme e grattacieli costituiscono lo sfondo di una vicenda che dal reale scivola nell’onirico, con sequenze simili a quelle già viste in From Eden to Hill. In più qui troviamo riflessioni sull’industria culturale che nei dialoghi finali dell’albo assumono quasi i contorni del saggio. Pur con qualche approssimazione nel disegno, Pyramid Inch si fa leggere con curiosità e lascia un senso di inquietudine e paranoia che è vera cifra stilistica.